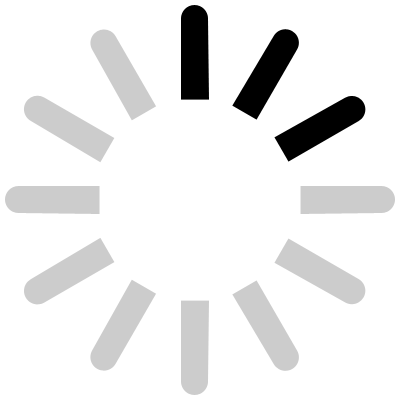Non sono per nulla sorpreso del duplice omicidio di mamma e papà a Ferrara, anzi mi sorprende che questi fatti non accadano più spesso. Se questo non accade, è perché c’è ancora un substrato solido nelle famiglie che fa da argine. Se accendete il televisore a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, ci si può immergere in telefilm con personaggi e metodi non distanti da quel che oggi ci descrivono le cronache. Si potrebbe dire che dal televisore “cola” sangue 24 ore su 24! Se poi aggiungiamo, la presunzione ipertrofica di essere immuni dalle influenze di questi programmi televisivi il cerchio si chiude. La televisione non è influente o innocua!
«Una volta si sentiva spesso la frase: “Ma lei non si vergogna?”. Oggi non si sente più. Probabilmente perché la risposta sarebbe: “Ma è ovvio che non mi vergogno. Perché mai dovrei vergognarmi?”. Vergogna è una parola scomparsa … La vergogna è il sentimento che si prova quando si sa di aver compiuto un atto che la coscienza morale condanna». Così leggo nel colloquio tra M. Viroli e Norberto Bobbio, Dialogo intorno alla repubblica. Non ci si vergogna più perché si è persa la coscienza morale.
Anzi, si è arrivati al punto di tacitare ogni rimorso mentendo spudoratamente, prima in pubblico, poi a se stessi. Il profeta Isaia tuonava: “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene e cambiano la tenebra in luce e la luce in tenebra” (5,20). Impressiona, perciò, l’arroganza dell’immoralità, la spregiudicatezza nel giustificarsi.
Ai nostri giorni si potrebbe ripetere la famosa domanda di Amleto. “O Vergogna, dov’è il tuo rossore?” (III, 4). Infatti, non si ha neppure più quel segno esteriore che rivelava un ritorno interiore di moralità, un sussulto della coscienza. L’espressione “faccia di bronzo” ben si addice a molti che con sfacciataggine occupano posizioni sociali, anche dopo palesi azioni ingiuste. O a coloro che, sono pronti, per servilismo privato, a incensare figure discutibili e operazioni illecite, senza nessun imbarazzo o reticenza.
Se non ne siamo più capaci, impariamo di nuovo a vergognarci e ad arrossire. Quella della perdita della vergogna è una delle più terribili esperienze dei giorni nostri, un vizio che non è più appannaggio dei vincitori, ma di tutti. Scherzando lo scrittore russo Anton Cechov parlava di un “bassotto che camminava per strada e provava vergogna di avere le gambe storte”. Ora, invece, le gambe storte, soprattutto le storture dello spirito, sono ostentate e diventano materia di spettacoli televisivi.
Come, invece, è profondo l’affermazione di un altro russo, Vladimir S. Solovev: “Provo vergogna, dunque esisto”.
“Se tu sapessi di morire oggi e vedessi il volto di Dio e l’amore, cambieresti? Se tu sapessi che l’amore può far breccia nel tuo cuore quando hai proprio toccato il fondo, cambieresti?” (Tracy Chapman). “Toccare il fondo”, una frase stereotipata, spesso ripetuta da molti: si usa, solitamente per lamentarsi della situazione storica in cui ci troviamo, e fa il correlativo con la domanda retorica “Dove andremo a finire?”. C’è, però, un uso ben più drammatico, anche se meno ridondante, ed è quello ricordato dai versi della Chapman: è la situazione di chi si è lasciato andare e, sprofondando come in una palude, non ha più né forza né voglia di tirarsi sù.
In quel momento è decisiva una sola cosa, che si cerchi di afferrare la mano che ti è offerta. Purtroppo, però, non di rado accade che non ci sia nessuna mano pronta a tendersi verso chi è precipitato. Si passa accanto veloci, ignorando i tanti fratelli o sorelle che avrebbero bisogno di un gesto, di una parola, di un affetto. Ma speso anche chi è caduto, non ha più nessuna voglia di attaccarsi a quella mano e risalire: lo sanno tanti genitori di fronte ai drammi dei loro figli. Ecco perché, penso, Chapman lascia la frase all’interrogativo che inquieta ma che può anche far sperare.
“Quando un male diviene così sparso dappertutto e così ordinario che se ne ride, è cancrena e non ha rimedio” (Francesco De Sanctis). Quando si perde il senso morale, quando si sbeffeggiano i valori e si adotta come metro di valutazioni il successo o il risultato materiale, quando si convive col disprezzo per la giustizia e ci si affida ai luoghi comuni della demagogia, si corre il rischio di essere in una società in cancrena. È necessario, perciò, un sussulto di moralità. Non ci si deve stancare di ricostruire le coscienze, di ri-proporre i valori veri, di ritornare alle radici spirituali. Anche a costo di essere socialmente perdenti, non si devono accettare compromessi con l’immoralità.
Anzi, è necessario definire nettamente a voce alta ciò che è bene e ciò che è male. “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro” (Is 5,20). Parole chiare che devono sovrastare la chiacchiera politica, l’imbonimento televisivo, il comodo quieto vivere.
Purtroppo, “Quello che caratterizza la nostra epoca è la volgarità, non solo nelle maniere e nel linguaggio, ma anche nel modo che essa ha di offrire un’immagine di se stessa; non la nasconde, ne è molto soddisfatta” (Julien Green). La colpa? Di tutti e di nessuno: il solito scaricabarile. Oggi è di moda la deresponsabilizzazione, o meglio, l’unica responsabile è la società.
E allora, che fare? Agire e reagire a tale andazzo. Incominciando dai maggiori responsabili: la TV, i genitori e la scuola. A mio modesto parere, chiunque non s’impegna in prima persona in tale battaglia commette un peccato grave di omissione. Quello che impressiona è l’ostentazione, la giustificazione, la soddisfazione di essere volgari. Il pudore non ha più cittadinanza, sconfitto com’è dalla sguaiataggine e dall’arroganza. Purtroppo, ai nostri giorni, a parlare di dignità, di finezza, di sensibilità, di comportamento, di educazione, di gentilezza si corre il rischio di essere sbeffeggiati.
Torniamo ai fatti di Ferrara. Due ragazzi di buona famiglia. Due famiglie normali: grandi lavoratori, con tutti i problemi quotidiani di ognuno di noi. Due ragazzi senza voglia di studiare, di rispettare le regole, senza responsabilità alcuna. Quei ragazzi li abbiamo educati noi. Potrebbero essere i nostri. Noi, che portiamo sulle nostre spalle la cartella dei nostri figli perché non ne sentano il peso. Noi che cerchiamo di non far mancare loro nulla, ma che non sappiamo testimoniare con la vita e i fatti, cos’è bene e cos’è male.
Ci alziamo presto per portare fuori il cane, ma ci addormentiamo senza riuscire a fare due chiacchiere con loro. Non li portiamo ai funerali per evitare che scoprano che esiste la morte, ma lasciamo che uccidano animali virtuali tutto il giorno con i loro video games. Noi che li chiamiamo per chiedere: “Dove sei?”. Ma che non chiediamo loro: “Cosa sei, cosa sogni, cosa vuoi fare della tua vita”.
Li difendiamo dalle intemperie e da ogni difficoltà, dimenticando che, l’affrontare la vita si impara passo, passo, da piccoli. Solo così crescendo saranno capaci di affrontare la fidanzata che non li vuole più, la moglie che se ne va, il datore di lavoro burbero. Abbiamo dimenticato che si educa insieme, con un’alleanza tra scuola, famiglia, nonni, allenatori. Invece, inveiamo contro l’allenatore, l’insegnante, usiamo i nonni come baby sitter e spesso usiamo i figli per dimostrare all’altro coniuge quanto lui sia incapace di fare il genitore.
Non basta gridare all’emergenza, qui si deve ricominciare a educare, tutti assieme, anche lasciandoci educare a nostra volta, chiedendo aiuto se occorre.